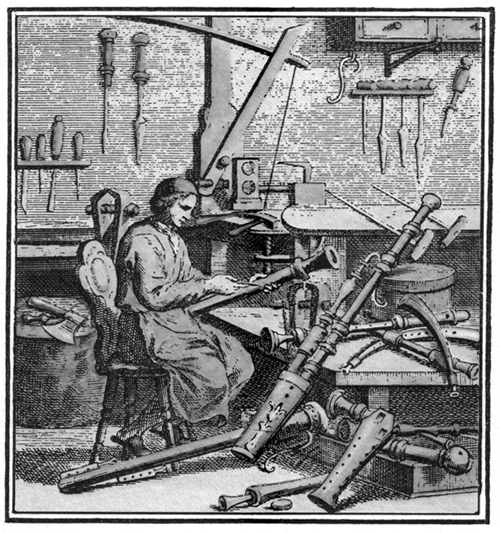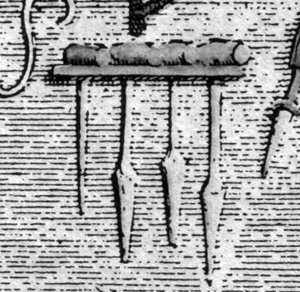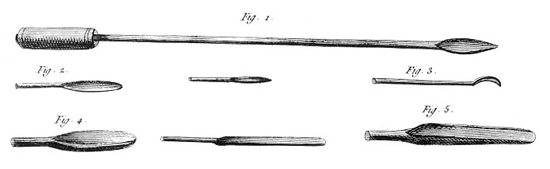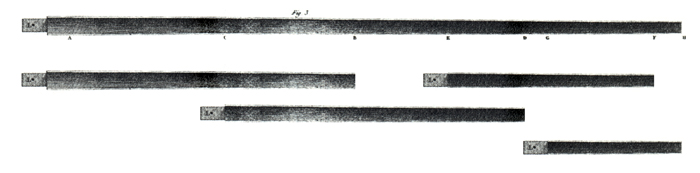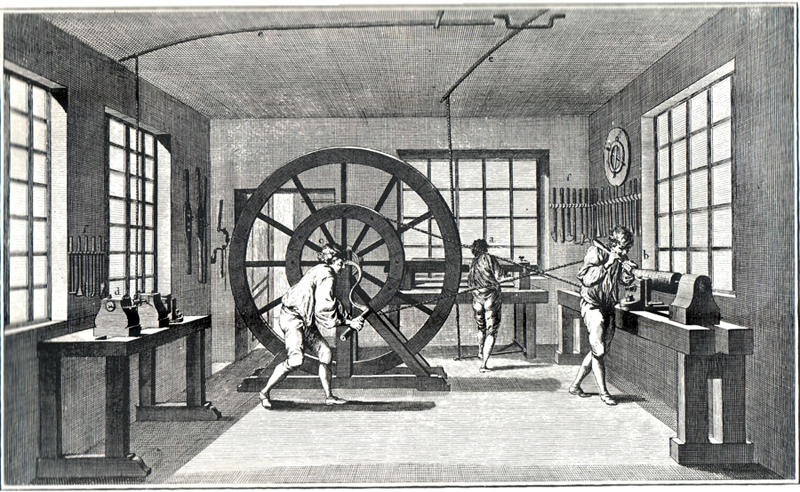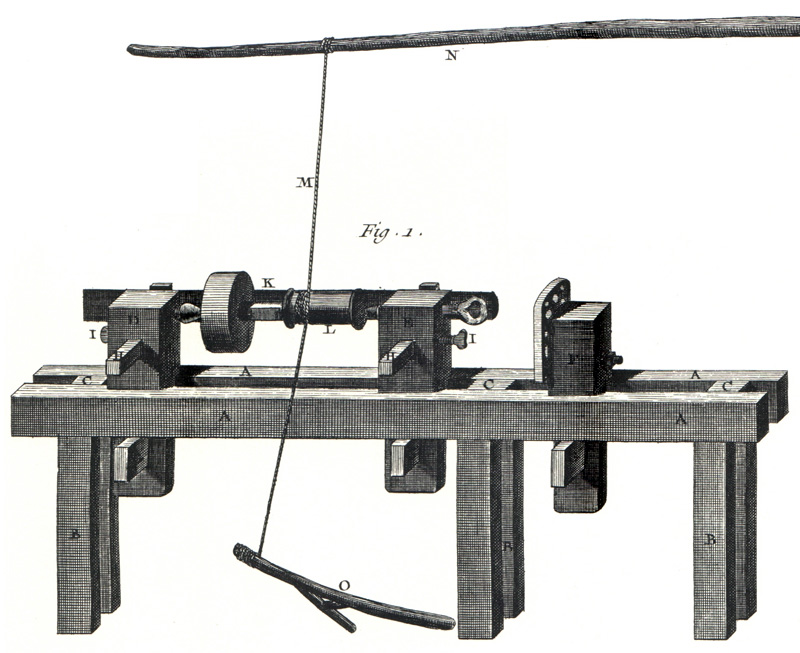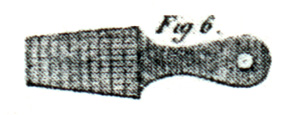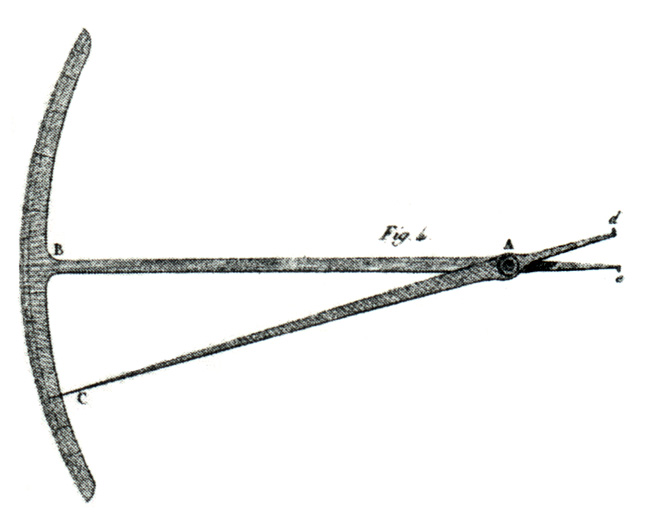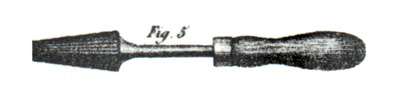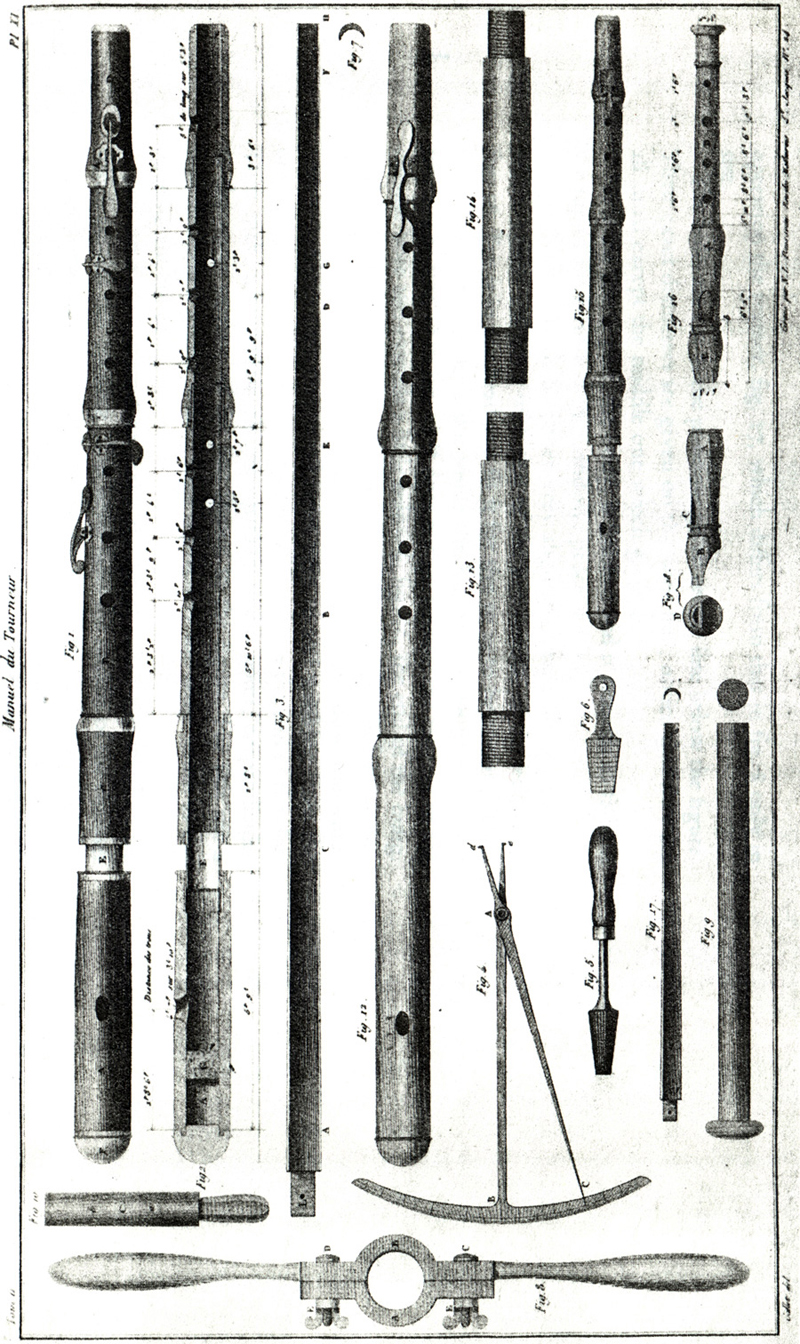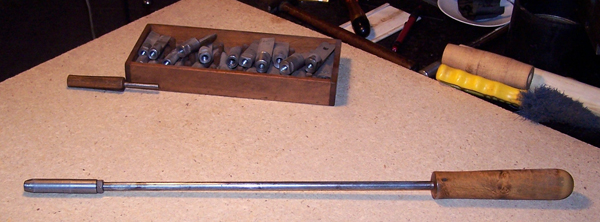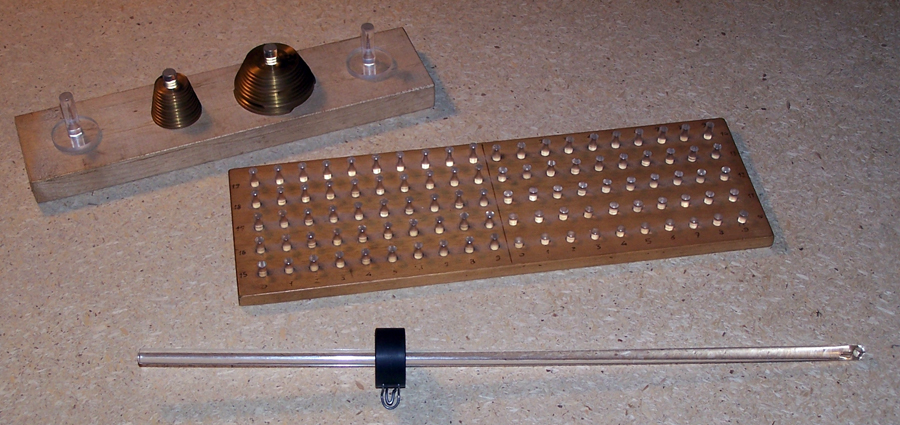|
***
Premessa
Quando si affronta la questione degli strumenti
originali si tende a concentrare l’attenzione su di essi in
quanto oggetti e sul ruolo di cui potrebbero essere investiti
nel tentativo di restituire un’immagine sonora convincente della
musica antica. Anche se con sempre maggior frequenza molti esecutori
ricorrono a delle copie, di rado la riflessione retrocede oltre
al loro darsi concreto: strumenti originali e copie sono sempre
già disponibili e si tratta solo di decidere se adottarli
o meno e, eventualmente, quale possa essere il loro reale contributo
nell’esecuzione.
In una prospettiva rigorosa, è corretto chiedersi
se dopo due o tre secoli uno strumento conservatosi in chissà
quali condizioni possa ancora avere un suono simile a quello
originario e allo stesso modo, nel caso di una copia, è bene
porre la questione del grado di fedeltà al modello. Un’opinione
forse datata, ma non per questo poco diffusa è stata espressa
da Jeremy Montagu nel lontano 1975:
The only way to copy an instrument is to copy
it exactly; the fact that it is then difficult to play
is immaterial, for it is up to the player to master it. Once
he has trained his musculature to produce good tone and good
intonation on an instrument identical to an original,
he is halfway to recreating the original technique and
the original performance style.[1]
Potrebbe essere interessante indagare quanto questa
visione sia effettivamente condivisa oggi: probabilmente molti
esecutori e molti organologi sarebbero più cauti nell’usare
aggettivi come ‘identico’ e avverbi come ‘esattamente’, ma ciò
non toglie che, complice anche la grande fiducia nelle ultime
tecniche di misurazione e riproduzione applicate alla costruzione
e al restauro degli strumenti musicali, la copia sia spesso
automaticamente intesa come oggetto riproducente l’originale
in ogni dettaglio. Problematizzare quest’accezione per certi
versi riduttiva di ‘copia’ significa anche aprire un altro ordine
di riflessione, che introduce nuovi aspetti da valutare tanto
di per se stessi, quanto in relazione al complesso di idee e
convinzioni di natura tecnica, storica ed estetica che riassume
lo stato attuale di una riflessione iniziata già sul finire
dell’Ottocento, con i primi approcci antiquari di Dolmetsch.
Più precisamente, si pone il problema di come costruire la copia
a partire dallo strumento originale.
È probabile che molti non siano d’accordo nell’includere
la considerazione di ciò che riguarda la realizzazione della
copia nella discussione sul significato da dare a quest’ultima.
È evidente, tuttavia, che ciò che si può pretendere da una copia
in sede esecutiva dipende innanzitutto dal suo modo di essere
copia, il che rinvia inevitabilmente ai principi e ai modi secondo
cui è stata costruita. In questa prospettiva, il ruolo dell’artigiano
si può dire rivalutato o persino riscoperto, in un’epoca in
cui il legame, un tempo indissolubile, tra un oggetto e il suo
processo di costruzione si è progressivamente allentato, giungendo
a volte ad annullarsi del tutto nell’anonimo isolamento dei
prodotti. L’abitudine di escludere automaticamente dalla considerazione
tutto ciò che riguarda il processo produttivo di un bene è profondamente
radicata in noi, ma non lo era affatto un tempo: intere generazioni
di famiglie come gli Hotteterre e i Philidor, tanto per fare
un esempio che ci riporti in ambito musicale, non solo componevano,
suonavano e insegnavano, ma producevano i loro strumenti, sperimentavano
e innovavano. Se fu proprio grazie a questa costante interazione
fra diversi ambiti di competenza che molti degli strumenti che
abbiamo ereditato hanno visto la luce, come si può pensare oggi
di prescindere dalla considerazione di quella che in realtà
è una vera e propria premessa metodologica al recupero della
musica antica?
Come sopra si è accennato, non è affatto scontato
che l’artigiano che deve realizzare la copia di un certo modello
debba operare solo passivamente limitandosi a misurare e a riprodurre.
Molto dipende dalle richieste del committente: se questo è un
museo, ad esempio, il requisito principale dovrà essere la massima
precisione possibile nella riproduzione di ogni dettaglio, ma
se il committente è un esecutore, professionista o dilettante,
potrebbero essere necessarie alcune modifiche imposte da esigenze
pratiche, come ad esempio quella relativa al diapason. Si profila
quindi una connotazione attiva del ruolo dell’artigiano, cui
viene richiesto di combinare la conoscenza dell’originale con
le personali doti di abilità ed esperienza. In questo senso,
dunque, si è affermato che il procedimento costruttivo costituisce
una premessa di metodo: il modo in cui l’artigiano costruisce
lo strumento determina a priori in quali modi esso potrà
essere suonato.
L’obiettivo di questo breve lavoro è quello di
analizzare il procedimento costruttivo di uno strumento specifico,
il flauto traversiere. Anche l’arco cronologico considerato
è piuttosto ben definito, dato che lo strumento è apparso attorno
al 1680 ed è stato impiegato professionalmente fino alla fine
del Settecento.
In un primo momento mi dedicherò a una rapida
ricognizione delle tecniche e degli utensili di cui potevano
disporre gli artigiani dell’epoca, facendo riferimento a una
delle pochissime testimonianze disponibili sull’argomento, il
Manuel du Tourneur di Bergeron. Si tratta di un’opera
rivolta a tornitori dilettanti, compilata alla fine del Settecento,
che nonostante i limiti connessi alla sua destinazione offre
un interessante compendio dei metodi e delle possibilità tecniche
della carpenteria dell’epoca.
Il tentativo di ricostruire il procedimento antico
sarà poi seguito da un confronto con la descrizione di quello
adottato da un apprezzato costruttore di copie di strumenti
storici a fiato, Michele Losappio, che ha gentilmente acconsentito
ad aprire il suo laboratorio.
PRIMA PARTE – IL METODO COSTRUTTIVO ANTICO[*]
I materiali
Nel periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo,
i materiali impiegati nella costruzione dei flauti traversi
e di molti altri strumenti a fiato di dimensioni paragonabili,
come ad esempio i flauti diritti o gli strumenti ad ancia, erano
sostanzialmente due: il legno e l’avorio. Quest’ultimo, in realtà,
era usato solo nella produzione di strumenti di particolare
pregio perché, anche se era apprezzato per l’eleganza e la bellezza,
presentava grandi svantaggi pratici nella lavorazione, era facilmente
deteriorabile e, soprattutto, assai costoso.
I primi accenni ai criteri di scelta delle essenze
nella costruzione di strumenti a fiato si trovano nella Harmonie
Universelle di Mersenne, riferite alle traverse:
Leur matiere peut estre de prunier, de cerisier
& des autres bois qui se percent aysément, mais on choisit ordinairement
du bois d’une belle couleur, & qui reçoit un beau poly, afin
que la beauté accompagne la bonté de l’instrument, & que les
yeux soient en quelque façon participans du plaisir de l’oreille:
on les fait ordinairement de buis; elles sont aussi fort bonnes
de chrystal, ou de verre & d’ebene.[2]
L’analisi degli originali conservatisi mostra,
comunque, che queste affermazioni restano valide per tutti gli
strumenti a fiato della sua epoca e anche per quelli del periodo
precedente. Mersenne fa esplicito riferimento a legni di susino
e ciliegio e accenna genericamente anche ad altri legni che
presentano la caratteristica di lasciarsi forare con facilità
ma, di fatto, il legno impiegato più frequentemente era il bosso.
Altre essenze in uso erano il pero e l’ebano, mentre spesso
gli strumenti di grandi dimensioni venivano realizzati in acero,
legno molto più leggero anche se particolarmente sensibile all’umidità
e, per questo motivo, inadatto a strumenti con cameratura stretta.
Circa un secolo più tardi Quantz affrontò l’argomento
nel suo trattato sul flauto traverso:
(§18) I Flauti sono formati di ogni spezie di
legno duro, come Bosso, Ebano, Legno reale, Legno santo, Grenadiglia.
Il Bosso è il legno più duro, e più ordinario per fare flauti,
ma l’Ebano rende il tuono più chiaro, e più bello; si deve foderare
il flauto con l’Ottone, come alcuni hanno provato, per fare
il di loro suono rampognante, rozzo e disaggradevole. (§19)
Siccome certe umidità penetrano nell'interno del flauto, che
si suona, le quali sono dannose, bisogna avere diligenza di
nettarlo spesso con un cencio appeso ad un bastone; e perché
tale umido non entri nel legno, conviene ungerlo qualche volta
con oglio di mandorle.[3]
Dall’analisi di queste affermazioni si possono
trarre interessanti considerazioni. In primo luogo, si può osservare
che, più di un secolo dopo le informazioni di Mersenne, il bosso
era ancora il materiale più diffuso, mentre i legni da frutto
non sono nemmeno menzionati. In compenso, l’ebano si era imposto
nelle preferenze di Quantz perché, grazie alle sue caratteristiche,
conferiva allo strumento un timbro più chiaro e bello, qualità
che egli cercava di intensificare anche tramite l’allargamento
della cameratura, che contribuiva ad accrescere la purezza e
la rotondità del suono nelle prime due ottave.
Notiamo, a questo punto, come l’attenzione di
Quantz per la qualità del suono e la noncuranza pressoché completa
per l’aspetto dello strumento si ponga in contrasto con l’atteggiamento
manifestato da Mersenne un secolo prima, caratterizzato invece
da un certo interesse per la bellezza del colore, la lucidatura
e, in generale, per la partecipazione della vista al piacere
dell’udito. Sebbene all’apparenza di poco conto, si tratta senz’altro
di un innegabile mutamento di sensibilità.
Un uso determinato da motivi esclusivamente estetici
fu, a partire dalla metà del XVII secolo, quello di trattare
la superficie esterna dello strumento con tinte scure o con
acidi che conferivano al materiale impiegato le sembianze di
un prezioso legno esotico. Naturalmente, il favore incontrato
da questi interventi dipendeva dai gusti e dalle convinzioni
personali: alcuni esprimevano totale disapprovazione, altri
apprezzamento per il risultato estetico sulle venature, altri
ancora una tolleranza accresciuta dalla convinzione che il passaggio
dell’acido potesse rinforzare la superficie del legno.
Un’interessante osservazione di Quantz riguarda
la manutenzione, con particolare riferimento al problema della
condensa che si forma abbondantemente all’interno del tubo già
dopo pochi minuti di uso dello strumento. Oltre a raccomandare
di asciugare l’interno con un panno applicato a un bastoncino,
egli osservava come alcuni legni fossero più sensibili di altri
al permanere della condensa e, in generale, più suscettibili
alle variazioni atmosferiche. Va detto che, quando uno strumento
viene suonato, il rapido passaggio dall’essere asciutto e, spesso,
freddo all’essere umido e caldo comporta brusche sollecitazioni
cui ogni tipo di legno reagisce diversamente. Il legno di bosso,
ad esempio, specialmente se non stagionato a dovere, è soggetto
a deformazioni, soprattutto in prossimità delle zone più delicate
dello strumento come i giunti tra i vari pezzi. Oltre agli effetti
estetici, le deformazioni possono influire sull’intonazione
del flauto e, nei casi più gravi, possono intaccare forma e
tenuta degli incastri tenone-mortasa, compromettendone anche
del tutto la funzionalità. Il legno d’ebano, invece, non è soggetto
a deformazioni, ma piuttosto a rotture o crepe, che possono
manifestarsi improvvisamente anche durante l’uso dello strumento.
L’accorgimento suggerito da Quantz e tuttora in uso oggi, era
di ungere lo strumento con olio di mandorle al fine di rendere
idrorepellenti le pareti interne del tubo ed evitare così gli
inconvenienti dovuti all’assorbimento dell’umidità.
Diversi esemplari sono giunti sino a noi privi
di crepe o deformazioni e, senza dubbio, il legname impiegato
per la loro realizzazione era stato meticolosamente stagionato.
Esisteva un tempo in Inghilterra una procedura segreta per la
stagionatura della varietà locale di bosso, che consisteva nel
seppellire il legname sotto miscugli di terra e letame, lasciandolo
riposare per vent’anni o più. Pare che i costruttori antichi
attribuissero particolari proprietà al legno stagionato secondo
questa tecnica, responsabile forse anche dell’accentuata colorazione
miele di alcuni strumenti in bosso che si sono conservati sino
ad oggi. D’altra parte, solo in un’epoca in cui i mestieri si
tramandavano di padre in figlio era possibile pianificare una
stagionatura così lunga, che faceva del legno un piccolo tesoro
per gli eredi.
Il procedimento costruttivo
In passato, la costruzione del flauto e, più in
generale, degli strumenti a fiato in legno non richiedeva competenze
diverse da quelle possedute da qualsiasi buon tornitore, anche
se probabilmente solo i più abili sarebbero riusciti a ottenere
un buon risultato. Gli utensili impiegati nella costruzione
degli strumenti sono descritti in alcune opere classiche sulla
tornitura, come ad esempio L’art de tourner en perfection
di Plumier (1701) e il Manuel du Tourneur di Bergeron[4]
(1792 e 1816) e compaiono anche nelle tavole dell’Encyclopédie
di Diderot (1751-1780).
Le testimonianze relative alla prassi costruttiva
dell’epoca sono invero piuttosto scarse e, del resto, l’iniziativa
di compilare descrizioni tecniche specifiche del procedimento
di costruzione non era per nulla conveniente: molto più saggio
era mantenere rigorosamente il segreto sui trucchi del mestiere.
Non si tratta di un caso, dunque, se l’unico esempio di una
simile descrizione ci è stato offerto da Bergeron, il quale
non era un costruttore, ma un noto avvocato. Grazie a lui, siamo
in grado di ricostruire almeno le fasi fondamentali del procedimento
che verosimilmente doveva seguire ogni costruttore dell’epoca.
Quanto ai dettagli di ogni singolo passaggio, data la notevole
variabilità in funzione della geografia e persino delle abitudini
dei singoli costruttori, nulla può essere detto a un livello
generale come quello della nostra trattazione: la disponibilità
di mezzi, l’ingegno, l’esperienza o le consuetudini di famiglia,
infatti, influivano profondamente sulle scelte costruttive e,
data anche la scarsa circolazione di informazioni cui si è fatto
cenno, una ricostruzione esauriente è probabilmente impossibile
da realizzare.
Tutto aveva inizio con la scelta del legno, cui
seguiva la sua riduzione in blocchetti di dimensioni adeguate,
vale a dire di poco superiori a quelle del pezzo finito. Per
un flauto in quattro parti erano necessari quattro pezzi di
legno della medesima densità e colore, in modo da garantire
un risultato finale il più possibile omogeneo. Le parti erano
ottenute per spaccatura piuttosto che per segatura e le ragioni
di tale preferenza risiedevano nel fatto che il ricorso all’accetta
assicurava che la rottura avvenisse in corrispondenza dei naturali
punti deboli della struttura del legno, laddove la sega avrebbe
interrotto le venature e alterato gli equilibri interni ottenuti
dopo una lunga stagionatura. I pezzi erano quindi passati al
tornio per sbozzarne la sagoma esterna e poi accorciati, in
modo da ottenere dei cilindri di diametro e lunghezza di poco
superiori a quelli finali. A questo punto, si praticava longitudinalmente
e centralmente un foro di piccolo diametro, molto più stretto
rispetto a quella che sarebbe stata poi la cameratura dello
strumento. Per questo passaggio si adoperava una sorta di piccolo
trapano o un alesatore e si fissava il pezzo al tornio con una
lunetta, la quale consentiva da un lato di mantenerlo fermo
e, dall’altro, di avere facile accesso all’estremità da forare.
I pezzi così ottenuti erano lasciati riposare ancora una volta
al riparo dal sole e dall’umidità e, grazie all’aria che poteva
circolare all’interno, la stagionatura avveniva in maniera molto
più rapida ed efficace.
Al termine di questa seconda stagionatura iniziava
la fase successiva della lavorazione, durante la quale veniva
allargato il foro pilota praticato in precedenza e veniva così
conferita alla cavità interna del tubo la sua forma definitiva.
Per compiere tale operazione venivano usati degli alesatori,
ovvero attrezzi simili a sgorbie, adatti alla lavorazione all’interno
del pezzo.
Dopo aver portato l’interno a forma definitiva,
si poteva passare alla realizzazione delle mortase. Si trattava
di fissare i pezzi al tornio, separatamente, servendosi di un
mandrino opportunamente sagomato che doveva essere preparato
con la massima cura poiché doveva far combaciare nel modo più
preciso possibile l’asse di rotazione del tornio con l’asse
della cavità interna del pezzo. In caso contrario, le pareti
esterne dello strumento avrebbero avuto spessore non uniforme
e, di conseguenza, l’incastro tra i pezzi avrebbe potuto essere
compromesso, così come le qualità sonore dello strumento. Esternamente,
in corrispondenza delle mortase, erano spesso presenti degli
anellini,[5]
di solito con funzione di abbellimento ma talvolta anche di
rinforzo. Il loro profilo interno era leggermente tronco-conico
e venivano incollati al pezzo subito dopo la lavorazione della
mortasa.
A questo punto si procedeva con la tornitura esterna
definitiva durante la quale erano realizzati anche i tenoni,
opportunamente dimensionati in modo da poter entrare agevolmente
nelle mortase. A causa delle continue sollecitazioni meccaniche
cui erano sottoposti, essi non potevano avere lo stesso diametro
delle mortase, ma era necessario che vi fosse un certo gioco
tra i due pezzi. La stabilità dell’incastro era poi garantita
avvolgendo del filo cerato all’esterno del tenone e, per evitare
che quest’ultimo si spostasse quando lo strumento era smontato,
si praticavano delle tracce circolari.
Il passo successivo consisteva nel praticare i
fori di diteggiatura, il foro della chiave e quello dell’imboccatura.
Una volta determinata la loro corretta posizione e il loro diametro
esterno si procedeva alla foratura per mezzo di un trapano dalla
punta leggermente più piccola del diametro del foro e si procedeva
poi all’allargamento dei fori pilota impiegando utensili di
vario tipo, ad esempio delle fresette coniche. Durante tutto
il procedimento era necessario controllare costantemente sia
la misura del diametro del foro in lavorazione, sia l’intonazione
e la resa sonora dello strumento, al fine di stabilire se l’allargamento
fosse sufficiente. Dopo quest’operazione, o anche contemporaneamente,
si praticava la svasatura interna dei fori. Anche in questo
caso gli utensili impiegati erano assai vari e molto dipendeva
dalle disponibilità e dall’ingegno del singolo costruttore.
Le ultime fasi di lavorazione prevedevano l’applicazione
della chiave, la preparazione del cappuccio di chiusura della
testata e, ovviamente, la prova dello strumento, alla quale
potevano seguire diverse fasi di ritocco della svasatura o del
diametro dei fori per ottimizzare l’equilibrio di intonazione
dello strumento.
Gli utensili del mestiere
Gli alesatori
L’alesatore è un utensile impiegato per la finitura
di fori conici o cilindrici, dotato di spigoli di taglio detti
taglienti in grado di asportare piccoli spessori del materiale
in eccesso. La prima rappresentazione iconografica nota di questi
utensili si trova nell’illustrazione di Christoph Weigel,
Der Pfeiffenmacher (1698), oggi parte della Dayton C. Miller
collection
(figura 1);
il dettaglio degli alesatori è rappresentato in
figura 2. Altri alesatori sono raffigurati nell’Encyclopédie
(figura 3) e un ulteriore esempio
si trova nelle tavole annesse al trattato di Bergeron
(figura 4).
Pur nella semplicità del disegno, gli alesatori
dell’illustrazione di Weigel si possono ricondurre al tipo illustrato
con maggior dettaglio nelle tavole di Bergeron. Indicazioni
precise sul loro impiego sono fornite proprio da quest’ultimo,
che spiega come essi dovessero essere fissati saldamente con
una morsa mentre i pezzi venivano inseriti e ruotati a mano.
Bergeron fornisce l’illustrazione di un unico
lungo alesatore da finitura
(figura 4, in alto), ma ne descrive anche altri quattro
di lunghezza inferiore per le corrispondenti parti del flauto,
ciascuno dei quali riproduce un determinato tratto dell’alesatore
di finitura. Ognuno di essi doveva essere più lungo dello stretto
necessario di modo che, quando l’usura ne avesse resa necessaria
l’affilatura, l’assottigliamento complessivo dell’utensile non
ne avrebbe compromesso la funzionalità.[6]
Molto inverosimile, invece, appare l’impiego del lungo alesatore
di finitura cui si è fatto cenno. Secondo Bergeron, esso avrebbe
dovuto essere usato sullo strumento già finito esternamente
e assemblato, bloccato in una morsa. La descrizione di questo
passaggio, così in contrasto con una valutazione dettata da
elementare buon senso, può essere un indizio in grado di confermare
il fatto che Bergeron non aveva mai costruito un flauto. Sembra
del tutto improbabile, infatti, che potesse essere prassi diffusa
quella di ruotare tutto lo strumento sull’alesatore facendo
leva su una morsa applicata a un solo pezzo perché i tenoni
non sarebbero mai rimasti solidali con le mortase; va aggiunto,
poi, che la testata del flauto, di forma interna cilindrica,
non avrebbe dovuto essere coinvolta in quest’operazione, ma
di questo dettaglio non è fatto il minimo cenno.
Quanto al concreto impiego degli alesatori, vi
erano due possibilità: essi potevano essere tenuti in mano mentre
il pezzo veniva ruotato, oppure si poteva ruotare l’alesatore
sul pezzo fissato a una morsa, a seconda della presenza o meno
di un’idonea impugnatura. Molto poco credibile appare invece
l’ipotesi che fossero usati con il pezzo caricato sul tornio
dato che la lavorazione, che richiedeva uno sforzo considerevole,
sarebbe divenuta pericolosa e potenzialmente incontrollabile.[7]
Assai diversi sono gli alesatori rappresentati
nell’Encyclopédie: essi, infatti, appaiono formati da
un lungo manico cilindrico e da una parte terminale raschiante,
con diverse possibili forme tra cui quella a cucchiaio (figura
3, n. 1), la quale permette di raccogliere il truciolo
durante la lavorazione per poi estrarlo assieme all’attrezzo.
Il modo d’impiego di questi alesatori non è del tutto chiaro,
soprattutto per quanto riguarda la lavorazione delle cavità
coniche caratteristiche della cameratura del nostro strumento.
Si può supporre che essi venissero usati a mano per realizzare
tratti cilindrici di diverso diametro, ad esempio decrescente,
in seguito raccordati con leggera abrasione per ottenere un
unico lungo tratto conico.
Il tornio
Il tornio è un utensile per produrre solidi di
rotazione. Ciò significa che ogni sezione di un pezzo tornito,
tagliata perpendicolarmente all’asse di rotazione, è sempre
circolare. A seconda del grado di evoluzione del tornio sono
possibili numerosi tipi di movimento e di interazione fra pezzo
e tagliente e tale versatilità ha motivato la straordinaria
importanza attribuita a questa macchina sin dall’antichità.
A partire dal III secolo d.C. furono apportati
notevoli miglioramenti, soprattutto in relazione al sistema
di rotazione: un capo della corda guida fu allacciato a un pedale
o a una staffa e poi fatto passare attorno al pezzo da lavorare,
mentre l’altro capo era legato ad un palo flessibile, posto
al di sopra del tornio. L’adozione di questa tecnica aumentò
notevolmente la potenza di rotazione e presentava il vantaggio
di lasciare le mani libere durante la lavorazione. Interessanti
esempi sono rappresentati in
figura 5, in
figura 6 sullo sfondo e, con la massima chiarezza,
in
figura 7. Queste ultime due
illustrazioni testimoniano che il tornio con il palo flessibile,
che ai nostri occhi appare molto rudimentale, rimase in uso
almeno fino alla fine del XVIII secolo, nonostante fossero disponibili
altre soluzioni (si veda ad esempio il tornio ad azionamento
manuale con due velocità,
figura 6).
Le testimonianze scritte risalenti all’epoca medievale
e rinascimentale sono piuttosto scarse, ma non mancano di interesse
come nel caso di un disegno di Leonardo da Vinci, appartenente
al Codice Atlantico, che ritrae forse il primo esempio di tornio
in grado di combinare una rotazione continua, resa possibile
dal ricorso al volano, con la possibilità di impiego indipendente
da parte di un solo operatore.
Il primo trattato specifico di tornitura risale
al 1701, anno in cui fu pubblicato L’art de tourner en perfection
dell’abate Charles Plumier. Nel 1678 Joseph Moxon si era occupato
di tornitura nel suo Mechanick Exercises or the Doctrine
of Handy-Works, il primo trattato inglese che illustrò e
descrisse l’uso degli utensili di vari mestieri, tra cui l’arte
del fabbro, la gioielleria, l’orologeria, la carpenteria, la
tornitura e la muratura. Più tardi, nell’Encyclopédie
compilata fra il 1751 e il 1772, Diderot e D’Alembert inclusero
molte tavole in cui erano illustrati il funzionamento del tornio
e i lavori che era possibile eseguire con esso. L’opera classica
della tornitura antica, tuttavia, rimane il Manuel du Tourneur
pubblicato da L.E. Bergeron nel 1792: comprende due volumi contenenti
ben 96 tavole e illustra in grande dettaglio quale fosse lo
stato di quest’arte all’epoca, anche se non era destinato ad
artigiani veri e propri, ma agli aristocratici che si dilettavano
di tornitura.
Verso la fine del Settecento il tornio subì una
profonda evoluzione che lo trasformò in una macchina molto sofisticata.
Il tornio moderno non fu inventato nel vero senso della parola,
ma fu il risultato di un lento e graduale processo di miglioramento.
Un passaggio chiave in questo sviluppo fu l’introduzione di
un volano separato dal mandrino con la funzione di mantenere
uniforme la velocità e costante il verso di rotazione. Già nel
1678 Moxon aveva descritto i vantaggi di questo potenziamento
osservando che il volano avrebbe permesso di eseguire il lavoro
molto più rapidamente rispetto a prima, quando il sobbalzare
del palo verso l’alto interrompeva di continuo la rotazione;
con un volano capace di immagazzinare l’energia e ridistribuirla
in modo uniforme, invece, il lavoro avrebbe potuto fluire senza
scosse e l’artigiano, mentre agiva con le gambe su un pedale
o su una manovella per fornire energia al tornio, avrebbe potuto
avere entrambe le mani libere.
Un altro importante miglioramento fu la sostituzione
della struttura in legno con una in ferro, materiale più resistente
alle deformazioni, che permetteva tra l'altro l’applicazione
di un carrello mobile sempre perfettamente allineato con l’asse
di rotazione.
Altri utensili
Molti altri piccoli attrezzi occupavano i banchi
da lavoro dei costruttori di strumenti a fiato. Tra essi, in
particolare, si possono notare alcuni strumenti per il controllo
della lavorazione e la misura degli strumenti. In
figura 8, ad esempio, è raffigurato un calibrino
conico, descritto nel trattato di Bergeron, munito di indicatori
in corrispondenza di diversi diametri di circonferenza: un simile
utensile era prezioso durante la fase di allargamento definitivo
dei fori di diteggiatura poiché consentiva di capire quanto
mancasse al raggiungimento della dimensione finale. Un altro
esempio può essere il calibro ad arco di
figura 9, descritto sempre nel medesimo trattato,
che consentiva di prendere misure dall’interno o dall’esterno
del tubo, mediante le punte d ed e, e di leggerne
il valore con una certa precisione rilevando la lunghezza dell’arco
BC sulla scala graduata.
Un altro attrezzo indispensabile era la fresetta
conica per l’allargamento dei fori, rappresentata in
figura 10, il cui impiego è facile da intuire. Molto
interessante, poi, è una seconda fresetta per la svasatura interna,
riportata in
figura 11, composta da un manico
provvisto di una comoda impugnatura e di un’astina filettata
nella parte terminale, cui andava avvitata l’altra porzione
dell’utensile, consistente in un piccolo tronco di cono zigrinato.
Facendo scorrere quest’ultimo all’interno del tubo sino al raggiungimento
del foro da svasare, era possibile avvitarvi il manico attraverso
lo stesso foro e sollevare l’attrezzo per raschiare, ruotando,
la parte interna della cavità.
Per completezza, la tavola tratta dal Manuel
di Bergeron è riprodotta integralmente in
figura 12.
SECONDA PARTE – INTERVISTA A UN COSTRUTTORE[**]
Per capire in quale misura i metodi costruttivi
attuali si discostino da quelli del passato si è pensato di
intervistare Michele Losappio, un noto costruttore di copie
di strumenti a fiato storici, il cui laboratorio si trova a
Castel San Gimignano, in provincia di Siena.
Per quanto riguarda i flauti traversi, fra i suoi
modelli di riferimento sono compresi due flauti di fine Seicento
e inizio Settecento, ovvero un Hotteterre e un Denner, un paio
di metà Settecento, ovvero un Villars e il classico Rottenburgh
(o anche un Palanca), e un Kirst di fine Settecento. Si tratta
di strumenti dalle caratteristiche piuttosto eterogenee, dal
punto di vista sia costruttivo che strumentale in senso lato.
Gli abbiamo chiesto di illustrare gli aspetti più propriamente
tecnici del procedimento da lui seguito per costruire la copia,
senza trascurare qualche riflessione sull’atteggiamento del
costruttore moderno nei confronti dell’originale. La discussione
ha avuto inizio proprio a partire da quest’ultimo punto.
Qual è, secondo lei, il rapporto del costruttore
di oggi con lo strumento d’epoca?
Penso che sia sostanzialmente simile a quello
che c’era tra costruttore e strumento all’epoca: si parte comunque
da un modello, solo che nel caso del costruttore moderno si
tratta di un esemplare antico, nella scelta del quale intervengono
fattori diversi come quello commerciale e la moda. A parte questo,
tuttavia, anche all’epoca i costruttori avevano di certo consolidato
un modello o più di uno, derivanti da altri precedenti con modifiche
più o meno consistenti, anche in relazione alle esigenze dei
musicisti.
Il fatto che siano trascorsi alcuni secoli e che
moltissime informazioni relative non solo alla costruzione,
ma anche alla prassi esecutiva siano state perdute per sempre
può indurre ad assumere un atteggiamento piuttosto rigido di
fronte all’originale, a fare cioè di ogni singolo esemplare
un modello.
Naturalmente, all’epoca c’era molta variabilità,
anche nell’ambito della produzione di uno stesso costruttore,
causata non di rado dalla non controllabile qualità del legno.
Premesso che è indispensabile studiare il maggior numero possibile
di originali per acquisire informazioni, capire i metodi di
lavorazione e individuare i modelli, due sono gli atteggiamenti
che è possibile assumere: mirare alla riproduzione più fedele
possibile di un particolare originale, che magari non può più
essere suonato, oppure far proprie le caratteristiche fondamentali
di uno strumento – come la cameratura, la posizione e il diametro
dei fori – e costruire strumenti dotati di vita propria, che
si discostano dall’originale in particolari più sfumati e aggiornati
alle esigenze dei musicisti. Di fatto, anche se in rari casi
può capitare che l’originale prescelto presenti già di per sé
caratteristiche compatibili con la nostra pratica musicale –
soprattutto relativamente all’intonazione e al diapason – di
norma accade che le richieste dei committenti impongano notevoli
forzature.
Personalmente, ritengo sia corretto fare in modo
che la copia somigli il più possibile all’originale, ma credo
sia altrettanto sensato costruire strumenti adattati alle nuove
esigenze. Un ruolo fondamentale, in questo senso, è rivestito
dai suggerimenti dei musicisti, che spesso richiedono aggiustamenti
imposti dalla viva pratica del loro strumento. Nel caso di strumenti
dal modello ben consolidato come quelli di fine Settecento,
queste modifiche sono piuttosto ridotte.
Oggi la prospettiva del costruttore è diversa
perché può contare sulla visione sinottica di una grande quantità
di modelli, dei quali può astrarre le caratteristiche locali;
è poi possibile preparare un catalogo con vari tipi di strumenti
da proporre ai possibili acquirenti. All’epoca, invece, ogni
artigiano aveva il suo concetto di strumento, il suo strumento.
Anche all’epoca c’era notorietà, commercio, scambio.
Tanto più che in merito alla costruzione degli strumenti a fiato
non c’erano molti segreti da custodire gelosamente come accadeva
invece nel caso dei liutai, che dovevano seguire un procedimento
costruttivo molto più articolato.
Via via che si conoscono strumenti nuovi, che
li si studia e li si misura, emergono caratteristiche che si
ripetono e ci si rende conto che, con il passare del tempo e
in modo molto chiaro verso la fine del Settecento, i modelli
si erano consolidati. Tralasciando le differenze regionali,
insomma, si può affermare che il procedimento avviatosi all’inizio
del Settecento, o anche prima con il flauto conico barocco,
era arrivato a maturazione completa nel giro di un centinaio
d’anni e che le forme si erano consolidate molto nettamente.
Nel caso di alcuni costruttori particolarmente precisi, si può
addirittura notare che il modello è sempre lo stesso.
Con quale criterio sceglie il materiale per costruire
la copia?
All’inizio della mia attività, vale a dire circa
venticinque anni fa, usavo del bosso locale. Il problema posto
dalla varietà nostrana, il Buxus sempervirens, non riguarda
tanto la qualità del legno in sé, quanto piuttosto il fatto
che da noi, normalmente, il bosso è potato a siepe e si trova
quindi solo in pezzatura corta e contorta. In seguito ho usato
anche varietà non nostrane di bosso, come il Buxus balearica,
proveniente dai Pirenei e molto conosciuto anche in epoca antica.
Normalmente, in Italia si possono trovare pezzi
di tronco del diametro di circa 10 centimetri, o di poco più
grossi. Bisogna tenere presente che, per raggiungere dimensioni
modeste come queste, il bosso impiega moltissimo tempo, circa
settant’anni e anche di più. Il Buxus balearica, invece
si può trovare con facilità in pezzature decisamente maggiori
(figura 13).
In commercio si trova già squadrellato oppure
in tronco e, generalmente, è piuttosto fresco e bisogna quindi
provvedere alla stagionatura. Ovviamente, si tratta di una fase
molto delicata.
Pare che, un tempo, fosse abbastanza diffusa l’usanza
di seppellire il legno sotto il letame per venti o anche venticinque
anni. Naturalmente si tratta di un metodo improponibile oggi…
Anch’io ho letto di quest’usanza di seppellire
il legno o addirittura di esporlo nelle stalle ai liquami degli
animali. Il vantaggio di questa pratica, probabilmente, derivava
dal fatto che alcune sostanze, come l’ammoniaca, avevano il
potere di evitare la formazione di muffe e, dunque, il deterioramento
del legno. Bisogna tenere presente, infatti, che se è vero che
nella prima fase di stagionatura è necessario conservare il
legno in un ambiente piuttosto umido per evitare che si secchi
troppo rapidamente, è vero anche che, nel caso di un tronco
appena tagliato e contenente moltissima acqua, succhi e sostanze
zuccherine, ciò significa esporlo al rischio di muffa. Non è
escluso, poi, che l’esposizione del legno ad un simile ambiente
chimico conferisse alcune particolari caratteristiche come,
ad esempio, l’apprezzato color miele. All’epoca era ben noto
anche il procedimento con l’acido nitrico, responsabile della
stessa colorazione miele, anche più scura ed ambrata.
Ad ogni modo, come è facile intuire, si tratta
di un procedimento che oggi nessuno usa più. Personalmente,
ritengo necessario lasciar passare un congruo numero di anni
dal momento di acquisto del legno, circa cinque o sei. C’è una
prima fase, che copre i primi due anni circa, in cui il legno
contrae notevolmente le proprie dimensioni, in modo assai diverso
a seconda che la direzione sia radiale o longitudinale. Se si
iniziasse a lavorarlo prima che essa sia trascorsa, quasi sicuramente
lo si spaccherebbe.
La stagionatura è un procedimento sulla cui durata
non è possibile intervenire: oltre all’evaporazione dell’acqua,
deve verificarsi un vero e proprio mutamento chimico legato
al filtraggio dell’ossigeno, la cui lentezza è proporzionale
allo spessore del legno. Se è possibile intervenire sulla diminuzione
dell’acqua, non lo è invece sul reale procedimento di stagionatura,
che non può quindi essere indotto artificialmente. L’equilibrio
è molto delicato, ma il procedimento è semplice: all’inizio
bisogna tenere il legno in ambiente piuttosto umido, facendo
sempre molta attenzione alle muffe; poi, man mano che procede
la stagionatura, lo si sposta in ambienti più secchi. Il freddo
non rappresenta un problema per il legno, ma bisogna aver cura
di tenerlo lontano dalle correnti d’aria.
Le alterazioni che si manifestano anche molto
tempo dopo la realizzazione dello strumento, come ad esempio
l’incurvarsi del legno, si possono ricondurre al processo di
stagionatura o vi sono altri fattori da considerare?
La tendenza a piegarsi, tipica del bosso, dipende
sia dal legno in sé, sia dalla direzione della venatura nel
pezzo, che dovrebbe essere il più dritta possibile. La scelta
ideale è quella fatta a partire da pezzi di quarto, ovvero tagliati
radialmente, in seguito lavorati cercando di escludere il centro;
quest’ultima accortezza, nel caso in cui il pezzo da eseguire
sia particolarmente grande, come una campana di oboe o di clarinetto,
non è sempre traducibile in pratica. Osservando gli originali,
comunque, si può constatare che questo criterio di scelta era
assunto anche dai costruttori antichi: la maggior parte degli
strumenti conservati, infatti, è stata costruita a partire da
un pezzo di quarto orientato sempre nello stesso modo, come
rivela l’angolo formato dagli anelli.
Anche le vicissitudini subite dagli alberi prima
del taglio e della stagionatura possono influire sul comportamento
successivo dello strumento. Determinante in questo senso è la
stagione in cui l’albero è stato tagliato: la stagione preferita
di norma è l’inverno, perché in quel periodo l’albero non è
in vegetazione e contiene una minor quantità di liquidi e sostanze
zuccherine.
Qual è il fattore prevalente che orienta la scelta
del tipo di legno da parte del costruttore moderno?
Salvo eccezioni, la tendenza prevalente è quella
di riprodurre gli originali con il legno in cui sono stati costruiti.
Per buona parte del Settecento l’essenza preferita è stata il
bosso; solo in un secondo momento, soprattutto all’epoca di
Quantz, l’ebano ha goduto di maggior fortuna.
La scelta di adottare lo stesso legno del modello
non è di secondaria importanza dato che i risultati sono sensibilmente
differenti. Poiché la tendenza comune dei costruttori antichi
era quella di mantenere il più possibile costante la massa degli
strumenti e poiché materiali diversi hanno pesi specifici diversi,
gli spessori venivano modificati, pur mantenendo inalterate
la struttura interna e le distanze. Tutto questo aveva un senso
e dovrebbe indurre un costruttore coscienzioso ad introdurre
modifiche nella realizzazione di una copia commissionata con
un legno diverso da quello dell’originale.
Quali sono le prime operazioni da compiere sul
legno pronto per la lavorazione?
Normalmente un tronco grosso viene aperto a metà
per essere lasciato libero di assestarsi. Non è detto che debba
essere subito ridotto a quadrelli, anzi. In genere ciò non è
conveniente perché in questo modo il legno è maggiormente esposto
alle deformazioni e quindi è meglio suddividerlo dopo un certo
periodo di stagionatura. Un’accortezza da adottare è quella
di paraffinare le estremità del quadrello per evitare un’evaporazione
troppo veloce attraverso i tubi tagliati. Una squadratura regolare
può essere fatta con una sega a nastro, oppure con una sega
a mano, probabilmente usata anche dai costruttori dell’epoca,
con la quale possono essere praticati anche dei tagli prismatici.
Secondo alcuni, l’impiego di una sega a nastro o circolare potrebbe
non essere senza conseguenze a causa della notevole velocità,
ma si tratta di affermazioni difficilmente verificabili.
In diverse fonti l’uso dell’accetta è nettamente
preferito, nonostante i suoi rischi, a quello della sega. Cosa
ne pensa?
Non ho mai usato l’accetta, anche se può avere
il considerevole vantaggio di seguire senza tagli la linearità
delle fibre del legno, evitando così che l’evaporazione avvenga
in maniera non omogenea, con velocità diverse in parti diverse.
In realtà si tratta di un accorgimento comunemente adottato
dai carpentieri, ai quali è ben noto che il legno segato dura
molto meno di quello spaccato: ciò dipende dal fatto che, in
corrispondenza del taglio, l’evaporazione dell’acqua è molto
rapida e si apre anche una via d’accesso ai parassiti. Nonostante
questo vantaggio, comunque, si tratta di una tecnica per nulla
diffusa fra i costruttori moderni, anche perché, probabilmente,
i colpi inferti con l’accetta inducono traumi meccanici notevoli
e microfratture che si possono manifestare in un secondo momento.
Va detto, poi, che un legno come il bosso, non presentando una
venatura regolare, non si può fendere con facilità. In conclusione,
insomma, si può quantomeno restare in dubbio che i vantaggi
derivanti dal ricorso alla spaccatura pareggino i rischi.
Abbiamo detto che la lavorazione ha inizio quasi
sempre da un quadrello
(figura 14). Come si procede?
Il quadrello viene stondato con una pialla o un
coltello, ma si può usare anche il tornio
(figura 15). Alla sgrossatura cilindrica può eventualmente
seguire un altro periodo di riposo, trascorso il quale si pratica
un foro pilota di circa 8-9 millimetri di diametro, tenendo
presente che i tratti più stretti nella cameratura di un flauto
barocco presentano un diametro di circa 11-13 mm. Non è detto
che il foro venga subito centrato con l’esterno: molto dipende
dalla tecnica impiegata. L’esecuzione di questo passaggio è
particolarmente delicata, soprattutto nel caso delle traverse
rinascimentali, dato che è praticamente impossibile realizzare
un unico foro perfettamente centrato di ben 60 cm. L’accorgimento
da adottare in ogni caso è quello di mantenere uno spessore
sufficiente per correggere il foro in un secondo momento.
Si possono usare punte di diverso tipo. Io ho
sempre impiegato delle normali punte elicoidali, da trapano,
ma ci sono anche le punte a cucchiaio, che scavano e raccolgono
il truciolo in modo che, quando le si estrae, quest’ultimo possa
uscire tutto in una volta. Ricorrendo a sistemi più sofisticati
e facendo uso del tornio, si può procedere forando da entrambe
le parti sino al centro, dove i due tratti si riuniscono.
Fino a questo punto, il procedimento non è molto
diverso rispetto a quello dei costruttori antichi. Secondo Bergeron,
giunti a questo stadio, occorre lasciar stagionare il pezzo
e, quando è pronto, si può procedere con l’alesatura e la rifinitura
dell’interno. A tal fine, prescrive l’uso di ben quattro alesatori
– uno per ogni pezzo dello strumento – e di un quinto per la
rifinitura, tronco-conico e di lunghezza pari a quella del flauto
montato.
Io ho usato più tecniche diverse. Per le alesature
coniche ho seguito un procedimento diverso da quello che indica
Bergeron. In realtà, anche se realizzabile, l’idea di ricorrere
a un alesatore lungo quanto tutto lo strumento è piuttosto poco
pratica. Personalmente, ho sempre usato degli alesatori conici
leggermente più lunghi del pezzo, dotati di uno o più taglienti
(figura 16) e il risultato che permettono di ottenere
potrebbe già essere considerato definitivo. Si tratta di coni
in acciaio cui vengono asportati uno o più spicchi in modo da
ottenere dei taglienti; questi ultimi non funzionano come un
fresa, quanto piuttosto secondo il principio della rasiera,
una lamina in acciaio in grado di tagliare sugli spigoli: la
lama viene affilata e poi, con un acciarino, viene schiacciata
in modo che il bordo sporga un po’ in fuori. Per poter compiere
quest’operazione, l’acciaio per gli alesatori non deve essere
troppo duro e ciò rende necessarie frequenti riaffilature, ogni
due o tre lavorazioni circa.
Ci sono due modi di usare un alesatore: è possibile
mantenerlo fermo e far ruotare il pezzo in lavorazione, oppure
fissarlo al mandrino e tenere il pezzo in mano.
In che modo si ottiene l’alesatore giusto per
ogni flauto?
A questo punto bisogna accennare a una questione
un po’ delicata, ossia al fatto che le camerature degli strumenti
originali non sono quasi mai un cono preciso, ma possono presentare
conicità irregolare o giustapposizione di tratti conici differenti.
In molti casi, probabilmente, i costruttori intervenivano successivamente
con alesatori più corti per apportare le necessarie correzioni
in alcuni punti.
In generale, quando ho scelto un originale da
riprodurre, procedo alla misurazione della cameratura interna
nel modo più accurato possibile, vale a dire con una tolleranza
dell’ordine di grandezza di mezzo decimo di millimetro. Esistono
svariati metodi: quello cui ricorro di solito è piuttosto intuitivo
e consiste nell’introduzione di calibrini campione in plexiglass
(figura 17) a diametri distanziati di un decimo di
millimetro, che si fermano quando incontrano la stessa misura
nel diametro della cameratura. Si misura la lunghezza di quest’ultima
in corrispondenza di ogni diametro e si costruisce un diagramma.
Confrontando diagrammi di strumenti diversi, è possibile risalire
al modello seguito da un certo costruttore e apprezzare il grado
di precisione con cui lavorava. Gli strumenti del primo Settecento
sono in genere più irregolari e ciò fa supporre che i costruttori
intervenissero di frequente in un secondo momento con altri
alesatori per rimediare ad alcuni problemi di intonazione.
Oltre a questo semplice metodo di misurazione
e senza considerare metodi estremamente sofisticati ma difficilmente
accessibili come radiografie, fotogrammetrie, eccetera, esiste
un altro sistema meccanico, non invasivo, che prevede l’uso
di un comparatore: misurando lo spessore da un lato, dal lato
opposto e il diametro esterno è possibile ricavare per differenza
una misura molto accurata del diametro interno. Questo procedimento
è efficace anche nel caso di camerature a botte e, dato che
può essere ripetuto con qualsivoglia angolo di rotazione, permette
anche di verificare quanto un pezzo sia ovalizzato.
Ricapitolando, per mettersi nelle condizioni di
poter eseguire una copia con un grado accettabile di fedeltà
sono indispensabili: una misurazione della cameratura, corredata
da una tabella che riporti i diametri per ogni decimo di millimetro;
una misurazione accurata dell’esterno, realizzata con un calibro;
un’osservazione attenta, preferibilmente con uno specchietto,
della forma dei fori compreso quello d’insufflazione, per il
quale sarebbe molto utile un calco.
Durante la costruzione delle copie, applico un
metodo di controllo della cameratura interna, al computer. Una
curva rappresenta il rilievo dello strumento originale mentre
una o più curve sono relative allo strumento o agli strumenti
in fase di costruzione. In questo modo è possibile verificare
se la lavorazione procede nella maniera corretta: è un controllo
molto accurato che, nel contempo, offre anche informazioni sullo
stato degli utensili. Di solito rilevo i dati ogni volta che
un mio strumento torna nel laboratorio e li conservo. È utile,
ad esempio, per stabilire se uno strumento ha bisogno di essere
nuovamente alesato.
Ha accennato al caso delle camerature a botte:
come le realizza?
Inizialmente usavo un metodo piuttosto semplice:
prima praticavo un’alesatura cilindrica e poi intervenivo con
carte vetrate via via sempre più fini per scavare l’interno,
controllando con una specie di sonda. Attualmente, invece, quando
c’è un buon rapporto fra la lunghezza e il diametro del pezzo,
che consenta cioè di entrare con una certa facilità, ricorro
ad un sistema di alesatura più sofisticato, messo a punto da
me e che probabilmente non è molto diffuso fra i costruttori.
Si tratta di una sorta di tornitura interna: il pezzo, con il
foro primario già praticato, viene fissato sulla lunetta e fatto
girare mentre si procede alla tornitura dell’interno con un
utensile molto lungo che ho costruito io stesso, agendo per
metà da un lato e per metà dall’altro. Si potrebbe definire
una tornitura a controllo numerico eseguita manualmente poiché
c’è una tabella che prescrive il diametro corretto per ogni
punto. È un metodo che consente di realizzare qualunque tipo
di alesatura e che presenta i due importanti vantaggi di non
rendere necessaria la costruzione di un alesatore per ogni pezzo
e di indurre sul legno un trauma assai minore rispetto al procedimento
tradizionale. Va detto che un metodo come questo non era di
certo alla portata dei costruttori antichi poiché, per ottenere
un buon risultato, è indispensabile poter disporre di un tornio
dalla meccanica perfettamente funzionante.
Bergeron si limita a dire di fissare l’alesatore
a una morsa e di girare a mano, lentamente.
Molti costruttori lasciano a questo grado di rifinitura
e, del resto, molti originali sono stati rifiniti così. Sono
però necessari accorgimenti particolari e grande attenzione,
perché con l’alesatura a mano è facile influire sulla centratura
del pezzo. Dopo l’alesatura è necessario controllare per cercare
di avvicinarsi il più possibile ai valori della tabella, intervenendo
anche con carte vetrate, con olio o a secco, sino al raggiungimento
di un risultato soddisfacente. A questo punto si taglia il pezzo
nel punto giusto – il pezzo va sempre mantenuto leggermente
più lungo del necessario – e la finitura interna è ultimata.
Si può quindi procedere con la finitura esterna del flauto.
E l’alesatura cilindrica?
Solitamente procedo come per l’alesatura conica,
seguendo il metodo che ho messo a punto e di cui abbiamo discusso
poco fa. In alternativa, si adopera un utensile con vari terminali
di ricambio a seconda del diametro
(figura 18). Ogni passaggio richiede interventi correttivi
sulla centratura perché capita di scavare più da una parte che
dall’altra. È probabile che utensili simili a questi fossero
usati dai costruttori antichi anche per realizzare alesature
coniche, dato che è molto più semplice agire su tratti corti.
Questa ipotesi appare confermata dal fatto che, negli originali,
si riscontrano talvolta tratti giustapposti, lunghi fino una
decina di centimetri, realizzati con coni diversi. Anch’io all’inizio
ho usato una tecnica simile, ma quando ho cominciato a costruire
gli alesatori ho preferito dar loro direttamente la forma irregolare
del pezzo.
Come si realizzano le mortase e i tenoni?
Interessano l’ultima fase della lavorazione, quando
è stata individuata l’intestazione definitiva del pezzo ed esso
è stato tagliato longitudinalmente, alesato all’interno e lucidato
all’esterno. Il pezzo viene montato sul tornio con la lunetta
e l’utensile per il taglio viene fissato sul carrello con una
leggera inclinazione, dell’ordine di un grado. Finita la lavorazione,
che verrà in forma leggermente conica, si procede incollando
l’anello già predisposto, anch’esso con sagoma interna leggermente
conica. La mortasa si fa con lo stesso utensile, ma operando
dall’interno: una volta decisa la profondità, si regola il tornio
in modo che l’utensile avanzi per la misura desiderata, sino
a terminare in battuta sul pezzo.
A questo punto, si può passare alla finitura dell’esterno.
Esattamente. Si fissa il pezzo al tornio dall’interno,
con uno spinotto, in modo che la superficie resti libera per
la lavorazione. Le parti cilindriche e pseudo-cilindriche sono
più semplici e rapide da realizzare, mentre nel caso di quelle
curve intervengo manualmente sgrossando dapprima la sagoma esterna
in modo da produrre dei gradini ed eseguendo poi il raccordo
a mano. La tornitura esterna è un’operazione piuttosto laboriosa,
ma non eccessivamente complessa.
Infine, si praticano i fori e si applicano le
chiavi.
Si tratta proprio dell’ultimo passaggio nella
costruzione dello strumento. Inizialmente si praticano dei fori
di circa mezzo millimetro più piccoli rispetto al loro diametro
definitivo e poi si procede allargandone l’interno per mezzo
di vari utensili, come coltellini o raschietti. Per forare si
usa il trapano a colonna: il pezzo viene fissato orizzontalmente
fra due supporti laterali con due tappi protettivi, usando una
punta di dimensioni adeguate; nel caso dei flauti non capita
mai di dover praticare dei fori in diagonale. Per svasare si
ricorre ad utensili piuttosto semplici, come limette o cilindretti
metallici ricoperti di carta vetrata e si procede controllando
l’interno con una guida di luce in plexiglass e uno specchietto.
Naturalmente, i fori hanno una disposizione ben
definita a seconda dal modello: in genere, negli strumenti la
cui produzione è ormai consolidata, la posizione e le dimensioni
sono ben definite, ma a volte è bene fare delle prove e intervenire
se sono necessari dei ritocchi. Altre volte, nel caso di committenti
esperti, tengo conto delle esigenze e dei desideri dei musicisti,
per cui si può affermare che alcuni di loro contribuiscano al
consolidarsi di un modello. A parte ciò, comunque, cerco sempre
di riprodurre con la massima fedeltà la svasatura degli originali.
E per quanto riguarda i trattamenti esterni?
Il bosso, di solito, viene verniciato per motivi
estetici. Esiste poi la possibilità di eseguire il trattamento
con acido nitrico, che tendo ad applicare anche a flauti i cui
originali sono in bosso naturale. Ritengo, infatti, che la finitura
influisca sul timbro dello strumento, migliorandolo sensibilmente.
Alcune riflessioni conclusive
Dal confronto fra procedimento antico e procedimento
moderno emergono senza dubbio alcune differenze ma, di fatto,
sembrano prevalere le somiglianze. All’origine delle prime si
colloca in modo più o meno diretto l’evoluzione tecnologica
subita dal tornio, che ha interessato sia lo schema del suo
funzionamento – con il passaggio dall’azione discontinua del
pedale alla rotazione continua impressa dal motore elettrico
– sia il grado di affidabilità e di precisione, sia, infine,
la potenza esercitata. In virtù di tale profonda trasformazione,
alcuni passaggi che un tempo erano eseguiti a mano o con altri
utensili, oggi possono essere eseguiti a macchina, con particolare
riferimento alle fasi di foratura iniziale e di alesatura. È
in operazioni come queste, dunque, che le innovazioni tecnologiche
apportate nel secolo scorso potrebbero aver influito nel modo
più consistente: tutto dipende dagli intenti che guidano la
lavorazione e dal modo in cui si ricorre ai mezzi disponibili.
Nel caso del procedimento illustrato da Michele
Losappio, una scelta che ha segnato un consapevole scostamento
dalla prassi probabilmente diffusa fra gli altri costruttori
è stata quella di adottare un metodo originale di tornitura
interna, che ha sostituito la tradizionale alesatura a mano.
La messa a punto di questo sistema ha richiesto anni e un lungo
studio degli strumenti, dei materiali e delle tecniche, arricchito
dalla considerazione delle valutazioni e dei suggerimenti degli
esecutori. Tutto ciò nel contesto di un ricorso limitato a risorse
tecnologiche sofisticate, su cui si pone in risalto l’iniziativa
di produrre in proprio e su misura gli utensili necessari.
Avendo consapevolezza di semplificare, si potrebbe
affermare che vi sono due modi possibili di sfruttare le moderne
tecnologie, corrispondenti ad altrettanti progetti di costruzione
della copia: ve n’è un primo che tende a riconoscere nell’elevato
livello di precisione consentito dall’applicazione dei metodi
più sofisticati una via di legittimazione della copia, che appare
così quasi come l’originale ritornato in vita, e ve n’è un secondo
che tiene conto delle innovazioni e spesso si serve di esse
come base per attuare una sperimentazione mirante a dare nuova
vita allo strumento. Si tratta dei due diversi atteggiamenti
che erano stati individuati ancora all’inizio di questo breve
studio e ai quali, in linea con quanto appena affermato, era
stata associata una connotazione rispettivamente passiva e attiva
del ruolo del costruttore. Vale la pena di precisare, forse,
che un’opera di ricostruzione come quella coinvolta nel secondo
caso non può avvenire senza una profonda conoscenza storica
da parte del costruttore, né senza l’onesta dichiarazione della
natura e della quantità degli interventi eseguiti.
Dal punto di vista di coloro che sono animati
da un intento documentario, il poter disporre di tecniche radiografiche,
ultrasonografiche e di risonanza magnetica, la possibilità di
realizzare disegni digitali, di servirsi di tecniche non invasive
per il riconoscimento delle essenze, delle leghe metalliche
e degli adesivi organici è, prima di ogni altra cosa, ciò che
mette nella possibilità di produrre copie di elevata fedeltà.
Sarebbe forse il caso di chiedersi, tuttavia, quale legittimazione
potrebbe avere la pretesa di realizzare una copia praticamente
identica all’originale nel caso in cui si sia poi costretti
ad introdurre modifiche imposte da esigenze pratiche. Fermo
restando che il ricorso a ogni innovazione che consenta la più
esatta acquisizione dei dati e la più fedele riproduzione dell’originale
è senz’altro legittimo e auspicabile nel caso in cui l’intento
sia puramente documentario, si potrebbe dubitare di poter affermare
altrettanto qualora la copia sia destinata all’esecuzione, dato
che il contrasto fra la minuziosità della riproduzione e la
consistenza delle modifiche imposte sarebbe davvero troppo stridente.
Un aspetto più prezioso della lezione degli antichi, forse,
è il ripristino della dimensione sperimentale e creativa, tanto
a livello costruttivo quanto a livello esecutivo, e ciò è come
dire che l’oggettività del recupero, tanto cara ai contemporanei,
non comporta automaticamente l’autenticità del risultato, la
quale potrebbe invece essere avvicinata in virtù del contributo
non controllabile, ma assai fecondo, del singolo costruttore.
In questo senso, si potrebbe addirittura affermare
che la differenza fra i due atteggiamenti sopra individuati
sia da ricercare piuttosto sul piano delle intenzioni che su
quello del risultato. Forse si può estendere anche al nostro
caso quanto fa osservare Cesare Brandi in merito alla copia
la quale, a prescindere dallo scopo che ne anima l’esecuzione,
proviene sempre da una cultura storicamente determinata e, di
conseguenza, è inevitabilmente orientata a documentare «quello
che le predilezioni o la moda del momento soprattutto apprezzano
e ricercano nell’opera, che non sarà mai l’opera nella sua totale
fenomenologia, ma questo o quell’aspetto». Da tutto ciò, conclude
Brandi, discende che «anche le copie hanno una data, rivelano
di appartenere ad un periodo storico, a meno che non siano state
ottenute con procedimenti meccanici, e anche in questo caso
sarà difficile, ma non sempre impossibile distinguerle dall’originale».[8]
In fin dei conti, come Losappio ha osservato,
è vero che il rapporto del costruttore di oggi con lo strumento
d’epoca non è dissimile nella sostanza da quello che c’era un
tempo fra costruttore e strumento: in entrambi i casi l’opera
dell’artigiano è ed era soggetta a vincoli, solo che nel primo
caso essi si impongono in virtù di un’autorità mentre, nel secondo,
il rispetto del modello aveva giustificazione eminentemente
pratica. Nulla doveva essere preservato in forza di una necessità
intrinseca, ma tutto era soggetto a miglioramento: nel modello,
infatti, si stratificavano le esperienze e le soluzioni più
efficaci ai problemi via via posti dalla viva pratica musicale,
per cui esso era, di fatto, un concentrato instabile delle migliori
innovazioni raggiunte a una certa data, in un certo luogo. Per
questo motivo possiamo ipotizzare che gli antichi forse faticherebbero
a comprendere le ragioni del nostro interessamento minuzioso
per dettagli destinati a essere aggiornati, a volte anche in
breve tempo, in funzione delle innovazioni tecniche e dei mutamenti
del gusto. Una manifestazione dell’atteggiamento decisamente
non astratto che li differenziava da noi, del resto, era l’assenza
di scrupoli che caratterizzò per secoli l’abitudine di intervenire
su strumenti di epoche precedenti con modifiche anche irreversibili,
determinate dalle esigenze del momento. Abitudine che, d’altra
parte, è apparsa particolarmente urtante solo negli ultimi decenni.
Questo stato di cose vige anche in altre arti,
non solo nella musica. Con la stessa noncuranza per l’oggetto
in sé, ad esempio, le pale d’altare venivano decurtate quando
le loro dimensioni non erano più adeguate alla nuova collocazione
e i rigattieri di Parigi mettevano in vendita sul marciapiede,
tra un vecchio ferro da stiro e un passeggino senza ruote, le
tele di Utrillo, del Doganiere e di Picasso. Oggi, tutti questi
oggetti sono gelosamente conservati, strappati ai loro contesti
originari e contemplati come testimonianze di una passata grandezza,
con una rigidità che espone al rischio di cristallizzare il
rapporto con l’oggetto antico.
Paradossalmente, a mio avviso, una connotazione
attiva dell’operare del costruttore di oggi, sia a livello dei
dettagli morfologici dello strumento, sia a livello di messa
a punto di nuove tecniche costruttive, avvicina nella sua essenza
il lavoro del costruttore antico più di quanto una copia idealmente
perfetta avvicini il suo modello, dato che quest’ultima non
sarà mai in grado di restituire un suono il cui inscindibile
correlato di gusto, sensibilità e tecnica esecutiva non può
essere autenticamente recuperato. Accostarsi alle vestigia di
ciò che un tempo partecipava di un’attività rigogliosa, vivace
e in costante mutamento con uno sguardo freddo e oggettivo non
potrà che moltiplicare la distanza che intende abolire, mentre
la ricerca di una sintesi con il gusto, la sensibilità e la
tecnica esecutiva di oggi potrà, forse, permettere di preservare
il più prezioso aspetto di continuità con il passato, una musica
non antiquaria, ma viva.
È plausibile, oltretutto, che se per ipotesi fosse
possibile ascoltare un’esecuzione antica, essa riscuoterebbe
assai meno consensi di quanto ci si potrebbe aspettare, anche
in considerazione del fatto che già le prime testimonianze sonore
tardo ottocentesche di esecutori apprezzati all’epoca lasciano
piuttosto perplesso l’ascoltatore di oggi. Molti, dunque, sarebbero
d’accordo con l’ammonimento di Robert Donington: «The effectiveness
of an authentic instrumentation cannot altogether be judged
or enjoyed, we must always remember, until the performance is
of the same professional excellence as would be expected
on modern instruments».[9]
Questa posizione, credo condivisibile, sbarra
la strada del ritorno al ‘suono degli antichi’, senza che ciò
comporti l’insinuazione – del tutto ingiustificata, del resto
– che la nostra tecnica esecutiva sia superiore a quella del
passato. Se si vuole far rivivere la musica, in modo che possa
avere un senso per noi oggi, essa dovrà pur portare in sé qualche
traccia di ciò che siamo, altrimenti rimarrà di fronte a noi
come un oggetto senza vita, con cui non si può interagire e
che può solo essere copiato con precisione sempre maggiore,
nel tentativo di eliminare la distanza piuttosto che in quello
di avvicinarsi mantenendola. La creatività dell’esecutore di
oggi non può essere oppressa da alcun «obbligo morale» di fedeltà
a qualunque costo, ma deve forse lasciarsi guidare solo da un
senso di «compatibilità artistica».[10]
A mo’ di conclusione, mi sia concesso citare le
parole di un filosofo che ha saputo guardare con particolare
profondità alla condizione dell’uomo nel Novecento: «La fretta
di sopprimere ogni distanza non realizza una vicinanza; la vicinanza
non consiste infatti nella ridotta misura della distanza. […]
Una piccola distanza non è ancora una vicinanza. Una grande
distanza non è ancora una lontananza».[11]
|